Attore o personaggio? Uomo o macchina? Operaio della B.A.N. o lavoratore odierno? 1968 o 2018?
Sono queste le dicotomie su cui gioca La classe operaia va in paradiso, spettacolo di Paolo di Paolo diretto da Claudio Longhi, liberamente tratto dall’omonimo film di Elio Petri del 1971. Una scelta audace, trasporre in immagini teatrali quegli scomodi fotogrammi che cinquanta anni fa destarono tanto scalpore da intimare la distruzione di tutte le copie. Una scelta audace se si pensa a quanto siano cambiate la società e le prospettive individuali in questo mezzo secolo.
L’idea dello spettacolo nasce nell’estate del 2016, durante un incontro tra Claudio Longhi e Lino Guanciale (che nello spettacolo interpreta il complesso protagonista Lulù Massa). La volontà è quella di inseguire il disegno per cui il teatro è un particolare specchio del presente, uno “specchio anamorfico”, per usare le parole dell’antropologo Victor Turner molto care a Longhi. Una superficie non liscia e asettica, ma che riflette deformando, rimpicciolendo, ingrandendo la realtà: la traveste. E il film nella sua inattualità viene a sua volta trasformato divenendo vividamente e tremendamente attuale, caricato anche di quella forza che solo il teatro, accadendo ogni sera davanti, intorno e con lo spettatore, riesce a dare. Il tema centrale del film quindi si sposta in questa messa in scena: non è più la lotta in sé di quegli operai alienati che caratterizzò i movimenti sociali di cinquanta anni fa, ma il lavoro nella società odierna che vive il 2018.
Parlare del lavoro attraverso la classe operaia si traduce in un gesto del tutto brechtiano. Portare in scena un mondo così lontano e distante ci aiuta a guardarci meglio. Questo specchio distorto che è il palcoscenico ci pone davanti a noi stessi, come individui e come società, riflettendoci e lasciandoci riflettere. L’immagine riflessa di noi individui è un’immagine che non siamo più disposti a vedere: quella del proletario. Quella di noi società è invece un’immagine che crediamo di intravedere, mentre ci ha abbandonati da tempo: l’immagine della coscienza di classe. E’ su questa visione che si aggomitola la sensazione di perdita che attraversa tutto lo spettacolo: la perdita di quella pulsione ideologica, scaturita da una consapevolezza di massa, che spinge a desiderare il cambiamento inteso come miglioramento. A sottolineare quest’elemento di perdita ricompare di nuovo Brecht, in una recitazione straniata, oggettivata, quasi in terza persona, di attori che sul palcoscenico calcano e ricalcano un contesto storico che non hanno vissuto e non potranno mai sperimentare.
Lo spettacolo vive di quelle vibrazioni che l’inseguimento ossessivo dell’ideale emetteva in quegli anni agitati. Lo spettacolo vive e trema. Trema di ossessione, di disperazione e di speranza e fa tremare il pubblico. Lo spettatore è scaraventato in una visione che lo mette in crisi, lo induce a porsi delle domande, a chiedersi a cosa stia assistendo esattamente. Come mai la rievocazione di un’epoca lontana e inafferrabile colpisce come un secchio di acqua gelida sul viso? E come mai quella disperazione esasperata, quell’ossessione, quel sentirsi un po’ uomo e un po’ macchina risultano così familiari da rabbrividire? E perché al contrario quella speranza e quell’arrampicata vigorosa di chi aspira a qualcosa di meglio sembrano così aliene ai nostri occhi?
La forza evocativa dello spettacolo sta nel suo continuo entrare ed uscire dalla narrazione. Gli attori interpretano più di un ruolo, alternando il tempo della storia con tutto ciò che è stato prima e dopo il film. La sua ideazione e costruzione, attraverso le parole del regista del film Elio Petri e del suo sceneggiatore Ugo Pirro, che sul palco osservano distanti ma allo stesso tempo interagiscono con il racconto; il carico e l’effetto che la pellicola ha trascinato dietro di sé, con gli attori che si immedesimano nel pubblico del cinema del ’71 ed esprimono i loro pareri e le loro critiche contrastanti sul film; la giovane coppia omosessuale che parla del film allo stesso modo in cui si chiacchiera tra amici del più e del meno, a dimostrare quanto i risultati del Sessantotto siano inconsciamente radicati dentro ognuno di noi; quella sorta di narratore-cantastorie che interrompe
bruscamente il racconto passeggiando tra il pubblico ed intonando con un pizzico di triste ironia i testi di Fausto Amodei e strappando qualche enigmatico sorriso.

La messa in scena, nonostante la sua durata di più di 2 ore e 30 minuti, rimane sempre chiara e incredibilmente fluida, dimostrando l’immane lavoro organizzativo alle sue spalle. L’ingegnosa scenografia permette cambi veloci e di grande impatto visivo, lasciando che lo spettatore venga catapultato da un luogo all’altro, dal passato al presente, dalla trama del film alla narrazione quasi senza accorgersene. La fabbrica incombe prepotente sui protagonisti e sul pubblico, senza mai abbandonare la scena. Il nastro trasportatore che ricorda la catena di montaggio scorre al centro del palco, trasportando elementi scenici ed attori, che, come oggetti, seguono il corso incessante della macchina inermi e impotenti, posseduti da essa. Il pannello quadrettato su cui vengono proiettate le scene del film ingabbia i personaggi inequivocabilmente. Li rinchiude senza via di uscita, se non quella di lasciarsi trasportare dal nastro senza opporre resistenza. Li rende prigionieri della fabbrica, delle loro case, dei loro pensieri, della loro vita e della loro ossessione. Con l’inganno rende anche noi pubblico prigioniero dell’inattesa presa di coscienza. Prigioniero di una gabbia da cui, paradossalmente, si è in grado di liberarsi solamente identificandosi nel Militina, l’uomo che dopo una vita chiuso in fabbrica si è tolto le catene perdendo il senno, divenendo paladino e profeta visionario di un sogno di rivoluzione. Uomo portato in scena da una donna, Franca Penone, a rimarcare la perdita di identità e di certezza, ma allo stesso tempo la scarcerazione dallo schema, dai modi che la società ritiene consoni e normali.
Come il Militina, tutti i personaggi assumono un valore proprio e vivono di una interiore polarizzazione. Non ci sono personaggi positivi e personaggi negativi. Personaggi per i quali parteggiare e personaggi contro i quali schierarsi. Sono tutti uomini che manifestano la loro dualità dal profondo. Sono, appunto, tutti uomini.

Lino Guanciale porta in scena un Lulù Massa, operaio stakanovista che finisce col farsi divorare dall’ossessione del lavoro e dall’alienazione della fabbrica, in grado di far ridere e di far piangere. La genialità dell’interpretazione riesce ad esprimere un personaggio fondamentalmente molto semplice ma dilaniato interiormente, con grande pathos e allo stesso tempo dolcissima ironia.
Particolarmente intrigante il cronometrista (Simone Francia), il personaggio più vicino alla figura del padrone, l’emblema della posizione che tutti si trovano prima o poi ad assumere nella società odierna: quella dello sfruttato che all’occasione diventa sfruttatore. Adalgisa (Donatella Allegro), la figura della donna femminile e desiderata, che nel contempo è un po’ “scoordinata”, per dirla con le parole dell’attrice. Una donna che si ritrova giovanissima nel contesto virile della fabbrica; manifesto della donna di quegli anni che vive in un mondo di rivoluzioni, compresa quella sessuale, e ha la voglia e la possibilità di goderselo, di esserci, ma non sa ancora bene come. Lo studente (Eugenio Papalia), personaggio problematico già nella versione cinematografica, rappresentato come paroliere astratto che insegue una rivoluzione solo con la voce e si tira indietro davanti alle conseguenze reali. Non mancano tuttavia i momenti in cui anche la sua più accesa gioventù, che sfocia spesso in una fastidiosa spacconeria, vacilla dimostrando un lato più umano, di un ragazzo che si trova davanti ad una società in fermento, ma è forse troppo giovane per sostenerne da solo il peso. Il sindacalista (Simone Tangolo) che appare spesso pavido, spaventato dall’idea della rivoluzione, ma è quello che prende in mano la situazione e media, ottenendo risultati, che per quanto possano essere delle vie intermedie, sono pur sempre reali. Interessante notare che l’attore che interpreta il sindacalista sia lo stesso che interpreta il cantastorie che conduce la narrazione: si identifica in lui una figura più stabile, su cui fare affidamento nei momenti in cui ci si sta più perdendo. Lidia (Diana Manea), la moglie di Lulù Massa, donna forte, alta, con i capelli corti, lavora sin da quando era una ragazzina e ci ha fatto le ossa in questo mondo di lavoro e insoddisfazione. Continua a sperare che il marito, alienato ormai anche nella vita privata forse persino più che in quella lavorativa, la voglia, la desideri e la ascolti. Disperata nella presa di coscienza dell’inutilità dei sentimenti e del fallimento nella ricerca della realizzazione personale. La splendida attrice, carica di forza emotiva e dalla voce potentissima, cita il suo personaggio, che aspira a poter un giorno comprare il famoso visone, simbolo dell’emancipazione economica, nell’affermare che oggi abbiamo tutti indossato un visone e non riusciamo a riconoscere la nostra pelle, poiché la società ci nasconde, nascondendo a noi stessi la nostra individualità.
In ultimo, uno spazio dedicato merita il musicista Filippo Zattini, polistrumentista eccezionale, che si ritrova a dover affrontare il confronto con un colosso quale Ennio Morricone, che scrisse la colonna sonora del film. La via intrapresa è quella dell’allontanamento dalla versione originale, per seguire un modello del tutto diverso. Le musiche si rifanno al ‘700, in particolare all’Inverno di Antonio Vivaldi, che con la ripetitività e ricorsività dei suoi fraseggi e ritmi collima con l’ossessione della fabbrica. Secoli così lontani si ritrovano a condividere lo spazio scenico, in un turbinio di follia e note. Il musicista è costantemente sul palco, in un angolo poco illuminato, al di fuori della gabbia. Pur non essendo un vero e proprio personaggio, si fa personaggio, tramite delle emozioni e dello stesso ingranaggio della fabbrica, tanto che i protagonisti interloquiscono con lui, zittendo più volte le sue note che esasperano fastidiosamente l’ossessione che rimbomba nei loro pensieri. Diviene quindi anche lui operaio, operaio dello spettacolo, ugualmente legato ad una macchina, per l’esecuzione della folle melodia.
Lo spettacolo è una miscela di emozioni, sentimento, nostalgia e risata. Fa ridere in maniera sincera e al contempo malinconica. Lascia nello spettatore una strana sensazione di voler uscire dal teatro e andarle a sfondare quelle famose porte del Paradiso, assieme a Lulù Massa, al Militina e a tutti gli altri. “Io c’ero?” chiedono gli operai a Lulù che racconta il suo sogno di conquista del Paradiso, nascosto dietro ad un muro e ad una coltre di nebbia.
C’eravamo tutti.
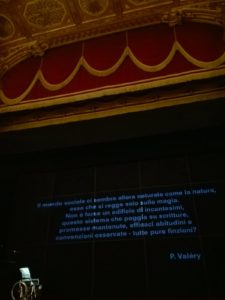
liberamente tratto dal film di Elio Petri
sceneggiatura Elio Petri e Ugo Pirro
di Paolo Di Paolo
regia Claudio Longhi
scene Guia Buzzi
costumi Gianluca Sbicca
luci Vincenzo Bonaffini
video Riccardo Frati
musiche e arrangiamenti Filippo Zattini
regista assistente Giacomo Pedini
assistente alla regia volontario Daniel Vincenzo Papa De Dios
con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, Franca Penone, Simone Tangolo, Filippo Zattini
Ada Turco


Assolutamente da rivedere!
Straordinario sarà un grandissimo successo